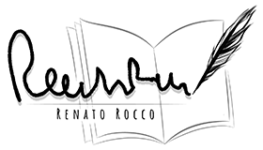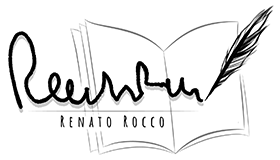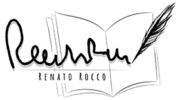Se la canzone è espressione culturale di un popolo, un mezzo tramite il quale si identifica la sua filosofia di vita, la serenata si colloca in una precisa nicchia.
Nelle vicende storiche di Napoli dobbiamo rilevare l’esistenza di un popolo plebeo e di uno aristocratico, con l’assoluta mancanza di una media borghesia fattiva e industriosa, esprimente valori pragmatici. Ognuna di queste componenti ha espresso valori con i mezzi più congeniali alla sua natura: la nobiltà adoperando un linguaggio ricercato, condotto massimamente per allusioni, tutte tese a convincere la donna, con argomentazioni rozze, a elargire le sue grazie amorose.
Tra questi opposti poi si colloca l serenata che, con alterna fortuna, intende dar corpo all’invito amoroso, lambendo prima la musica classica e straripando poi, nell’800 aduna esibizione canora con l’accompagnamento di strumenti a plettro, facilmente trasportabili, esibendosi in «pieces» che ben potessero interpretare i sentimenti dello spasimante. Non sempre la serenata è univoca nel proporre o descrivere l’intensità del sentimento del questuante: spesso contiene imprecazioni verso l’indifferenza o l’ostilità della donna amata, ovvero recriminazioni verso la crudeltà della donna che spesso si concludono con minacce di suicidio regolarmente rinnegato, o maledizioni di morte. Come trasmissione del pensiero amoroso, la serenata spazia in tutti i campi dell’agire umano: dalla contestazione del dispetto alla volgarità dell’imprecazione, con corollario di accuse infamanti e maledizioni. Un grosso supporto al successo della serenata è dovuto all’influenza dell’opera lirica che non disdegna l’uso frequente di serenate nel corpo dell’opera, come si rileva nelle serenate di Lindoro del Barbiere di Rossini o del Trovatore di Verdi.
Non abbiamo quindi un modo univoco di espressione, con regole codificate, ma la natura stessa della esibizione favorisce la libertà creativa. Molte volte la serenata non è comunicazione diretta, ma si avvale di una serie di espedienti, tutti finalizzati a far da tramite tra lo spasimante e la bella. Dalla vasta produzione di serenate accenneremo solo alla regina di questo genere, bella per la sua esemplarità: «Guapparia» di Falvo-Bovio tutta giocata sulla contrapposizione tra la debolezza di un forte e la «fortezza» di un debole. Ci troviamo di fronte alla solita accusa diffamatoria rivolta alla donna che per la canzone è deviante verso i propri impegni sociali e rigore morale. Guapparia si ricollega anche idealmente alle stornellate toscane di canti a dispetto.
E’ univoca la finalità della serenata: essa serve a convincere la donna tiepida a concedersi allo spasimante. Su quest’alveo principale si innestano varie situazioni, tutte di carattere gregario, ma tutte intese a raggiungere l’appagamento amoroso.
C’è chi si attesta su posizioni di minima richiesta come in «’Na voce ‘na chitarra e o poco e luna» che attonito si domanda «e che vuò chiù pe’ fa ‘na serenata».
Agli autori Calise-Rossi si può applicare l’aforisma di Oscar Wilde: toglietemi il necessario e mi accontenterò del superfluo. Di ben diverso avviso sono Murolo-Tagliaferri che in «Mandulinata a Napule», (è il caso di dire che non badano a spese) aspirano, per esternare il loro sentimento, ad una dimensione faraonica «voglio’e parole cchiù d’ammore ardente/ voglio ‘e parole cchiù gentile e care». Un eclatante caso di egoismo canoro lo troviamo in E.A.Mario con «io, ‘na chitarra e ‘a luna» dove esprime una ingiustificata volontà di isolamento: «Canto pe’ mme, canto pe’ mme/ nun voglio chiù a nisciuno/ io, ‘na chitarra e’ a luna». All’autore che rigetta la solidarietà altrui, non viene in mente di trovarsi di fronte a una necessità, specie se il tempo è nuvolo e manca la luna. Sempre dello stesso autore, in «comme se canta a Napule» vi è un tentativo di riordinare la materia offrendo un codice di comportamento canoro «e basta sulamente nu mandulino a vantà e’ trezze belle e l’uocchie doce».
Va giustificato con un eccesso di indulgenza dovuto all’entusiasmo, il patente feticismo cui involontariamente l’autore si abbandona sulle trecce. Citiamo come punta di un iceberg l’inesausta fantasia che trabocca nelle serenate, arrivando finanche a deplorevoli violenze, come nel caso di «Suspiranno» di Murolo-Nardella: «… ‘na puntigliosa cu nu muso astrinto e nu suspiro mio ca vasa ‘nfronte, ll’arape a vocca e ce se ‘nfizza dinto…». Dopo aver visto il fine della serenata esaminiamone i mezzi: la chitarra e il mandolino sono i due cardini sui quali si incentra la serenata; il secondo è più specifico ad un intervento condotto sulla pubblica via. Esistono due tipi di mandolino: quello napoletano a quattro corde metalliche e quello milanese, fatto con budella animali. Conviene dichiarare senza infingimenti che quest’ultimo quando produce un lamentevole miagolio è da ascrivere certamente ad un ultimo anelito vitale del «gatto» usato. Si tratta di miagolio e non di un lamento essendo questo una pura e semplice realtà partenopea la cui resa artistica raggiunge il diapason quando è esercitata da un disoccupato che riesce ad evocare, specie se di fronte a una telecamera, tutte le ingiustizie patite. Il mandolinista napoletano alligna e folleggia nei concertini dove dà buona prova di sé portando le serenate convincenti a far decadere la bella dalla sua riottosità. Il mandolino, che ben pochi napoletani hanno mai visto, appartiene al mito come il ragù e la pizza. Anche facendosi da mallevadore ove con subdola maestria, convince le riottose fanciulle a concedersi. Da questa oleografica dimensione ne esce il ritratto deleterio di un napoletano dedito per l’intera giornata a grattare le corde dello strumento.